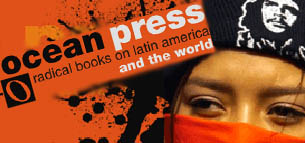La scrittrice equadoriana Cristina Burneo Salazar ha ottenuto il Premio Casa de las Américas nel dipartimento di Studi sul latini negli Stati Uniti per l’Opera Dime si son latinxs. Scritture della diaspora equatoriale negli U.S.A.
Lo scambio con lei, in posta elettronica, è cominciato con questa indagine che punta al quando.
Vogliamo sapere dei suoi inizi, che ci dica in che momento decise di mettere il suo talento in funzione della causa dei più miseri.
«Io hocmincitoa scrivere poesia a 13 anni. Poi come giovane scrittrice ho vissuto in un ambiente di autori che disprezzavano il pensiero delle donne.
Per dar valore al mio lavoro mi dicevano che io scrivevo come un uomo o ridicolizzavano le altre. Sempre ho voluto scrivere, ma non ho mai amato questo mondo nonostante quello che appreso in lui. Più avanti ho incontrato femministe e donne poderose che mi hanno mostrato un altro cammino e si dedicavano a creare mondi diversi e ricchi.
Poi sono diventata responsabile culturale, e lì mi sono formata con grandi donne che aprivano cammini nella cultura e nelle lotte di genere nelle arti.
Le vedevo con ammirazione e intendevo perché mi sentivo sempre peggiore tra maschi colti.
Tornando inEquador dopo aver vissuto negli Stati Uniti e un periodo in Belgio, dove ebbi sempre problemi migratori e di discriminazione, cominciai a relazionare il mio lavoro come scrittrice con le lotte sociali in forma più cosciente.
«Io non ho vissuto le violenze che soffrono coloro che vivono il razzismo anti negro, l’esclusione per essere un’emigrante, tra altre molto gravi, ma vivo in un mondo dove ogni racconto e ogni poesia si scrivono su questi terreni.
Questa realtà lo attraversa tutto e io ho voluto dar conto di qusto attraverso la scrittura individuale e collettiva».
–Come nasce la sua inclinazione verso le problematiche dei latinxs, in condizione di diáspora?
–Ho vissuto negli Stati Uniti diversi anni e ho ottenuto lì il mio Dottorato in Letteratura. La mia stessa circostanza là, essere parte di questa diaspora, ritornare e poi andare e venire, mi hanno condotto a inquietarmi per le emigrazioni contemporanee».
Nel documento di validità del Premio si assicura che l’opera tratta con rigore l’eterogeneità della latinità negli USA, la sua complessità,
creatività e le diverse forme di resistenza.
Del suo contenuto, Cristina ci ricorda: «Il libro ha come titolo i versi di una canzone di Proyecto Uno per affermare che la latinità è moltissime cose e soprattutto una domanda.
In /Dime si son latinxs…/, ho voluto mostrare latinità andine, che attraversano il continente per passare la frontiera delle frontiere, e vengono da popoli poco nominati, ma che sostengono il mio paese sulle spalle con il loro lavoro di decenni, mntre qui parliamo di "rimesse" a secco, senzn corpo».
In queste latinità, spiega, «ci sono migrazioni precedenti di decenni, poeti transnazionali, nuove lingue come misture del castellano in qusta regione con l’inglese e la lingua kichwa, musica, lutti non fatti, prosperità e pericolo di morte, tutto nello stesso tempo e ugualmente il latino è anche la musica di JLo!
Per questo, è necessario narrare, caratterizzare, leggere profondamente in questa diversità.
«Per parlare di latinità negli Stati Uniti, prima si deve parlare di numerose migrazioni. Una diaspora è anche una forma dell’affetto che affronta l’assenza, è un modo del corpo che apprende a respirare in più di un luogo ogni volta».
-È stato molto emozionante ascoltare il suo messaggio di gratitudine nelquale ha dedicato il premio «alle persone migranti e a quelle che stanno lottando contro la deportazione, adesso, con le loro stesse vite, negli Stati Uniti.
–Credo che i fascismi contemporanei riguardino tutto il mondo, perchè colpiscono la vita in tutti i suoi aspetti e oggi ritornano con un’enorme aggressività.
In mezzo a tutto questo, noi che ci prendiamo l’impegno di pensare questo mondo di tante maniere diverse, possiamo persistere facendo che ardano domande che ci agitino, domande che impediscano di entrare in letargo sotto l’ombra del senso comune fascista o totalitario.
«Nom smettere di denunciare potrebbe mitigare gli effetti del danno che stiamo vivendo, impedire che si normalizzi. E poi, intervenire sempre che sia possibile: se abbiamo guadagnato una voce pubblica, la devono ascoltare. Di fronte alla morte, la transfobia, la deportazione come spettacolo, ogni abuso di potere, la misoginia, la guerra... il silenzio è complicità: questa frase non si disperde, va rinnovata in ogni contesto dove vediamo ingiustizie».
C’è un compito che si crede urgente per le persone considerate come intellettuali: «ampliare il loro sguardo per intendere tutte le forme di protesta del presente, le loro visioni sulla vita e la resistenza.
Poco tempo fa sono stata in un ballroom, una sessione kiki che riunisce performers, voguers e artisti sexo dissidenti, per ballare meentre sfidano la etero-normatività.
Hanno performato varie persone perseguitate per la discriminazione e l’irregolarità.
Non farei mai un romanzo sulla violenza razzista, nè xenófoba, ma vedere in questo spazio come si fa la comunità nonostante tutto, con tanta insolenza e senso di liberazione, è un esempio.
Mi sono sentita fortunata di stare lì, per apprendere come accompagnare, resistere, gestire la vita, agire». ( GM/ Granma Int.)