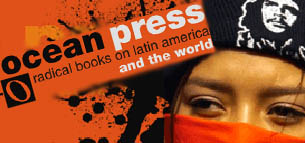Forse la prima volta che un uomo si trovò di fronte al fuoco corse via terrorizzato. Anche se non esiste un momento esatto per collocare quell’avvenimento nella linea rappresentata dalla nostra storia.
Ci volle tempo, molto tempo sino a quando riuscì ad avvicinare le dita alla fiamma ardente, gestirla, toglierla dal fulmine terrorizzante e metterla ai suoi piedi come uno strumento che vinse l’oscurità e il freddo.
Il nostro passaggio per questo mondo costituisce una collezione incalcolabile di prime volte che poi si ripetono sino a diventare routine.
Tutte le generazioni hanno dovuto affrontare il proprio fuoco: spaventarsi, recuperarsi dalla costernazione e metterlo ai propri piedi.
A noi l’incontro con il terrore produsse un’apnea profonda, paralizzante. L’umanità trattenne la respirazione e un virus le entrò nei polmoni, danneggiò il suo cuore e si estese sino al resto degli organi come un’infermiera sistemica.
Parigi restò deserta. Gli aeroporti custodirono i loro aerei e sembravano giocattoli di plastica perfettamente allineati in una spianata. I giorni cominciano ad avere il ritmo delle statistiche di morte e contagio, di dolore e commiato.
Si applaudì anche il coraggio dei lavoratori della Salute e di tutti quelli che correvano rischi per salvare altri.
I titolari parlavano di vaccinazioni nuove e anche se non citarono mai con affetto le nostre, il tempo le ha collocate giustamente sul piedestallo che meritano.
In mezzo a questo caos una donna diede alla luce una bambina. Cento anni prima, quando l’Influenza Spagnola decimava la specie umana, un’altra donna, trisavola, spinse sino a che la levatrice haitiana consolò il pianto del bebè appena nato.
Proprio qundo la piccola di questo secolo soffiava sulle tre candeline, Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS), dichiarò la fine dell’emergenza per la pandemia. Solo alcuni giorni prima, il 30 aprile, erano stati notificati circa 6,9 milioni di morti nel mondo per la COVID-19.
Il mondo, che tuttavia starnutava, cominciò a respirare con meno difficoltà. I suoi polmoni iniziavano un processo di recupero, come il resto dei suoi organi. Ma la guerra era lì come una patologia cronica, praticamente congenita, capace di mandare in necrosi le zone più distali e far sì che il pianeta si ritorca dal dolore.
Questo 2023 ostenta il disgraziato record della maggior quantità di conflitti all’unisono negli ultimi 30 anni, con un totale di 183. In conseguenza, il numero dei morti aumentò del 14 % e i fatti violenti del 28%, come riporta l’Istituto Internazionale degli Studi Strategici di Londra
(IISS, la sigla in inglese).
Ma gli occhi dell’orrore sono gli stessi in tutte le epoche. Con questo sguardo profondo, di spazio aperto, un bambino palestinese segue una
stella cadente e l’abbatte una bomba. Con la stessa espressione nel suo volto, vari decenni prima il piccolo ebreo si piegò dal dolore davanti alla morte e un bebè a Nagasaki, guardò il firmamento prima del’orrore della barbarie.
Non esiste una forma per misurare la disperazione umana. Non è stata inventata un’unità affidabile che l’esprima, ma poche cose dicono più del silenzio di una sguardo triste, e molti sguardi tristi li incontriamo in Turchia e in Siria, quando il fatidico terremoto del febbraio scorso, e nell’incidente di treno in India, nel quale persero la vita centinaia di persone e nei popoli dei quali non parla nessuno e che appartengono alla statistica dei circa 200 conflitti attivi nel globo della Terra.
Come un paradosso, il dizionario di Oxford ha fatto conoscere la parola dell’anno in lingia inglese. Si tratta di Rizz, un vocabolo usato dalla
Generazione Z per riferirsi a «stile, fascino o attrazione».
Questa forma abbreviata di carisma è diventata virale nel giugno scorso, quando l’attore Tom Holland, lo Spiderman moderno, la usò in un’intervista.
Fuori dalla geografia delle reti sociali d’internet, del metaverso della perfezione, questi 12 mesi non sono stati tanto «civettuoli», e sì che abbiamo necessitato una legione di super eroi, non perchè sparino
ragnatele, ma perchè curino le ferite sanguinanti d’una pandemia.
L’economia mondiale tuttavia non si recupera dalla turbolenza provocata dalla disseminazione del SARS-COV-2 e dalla guerra tra Russia e Ucraina, che ha provocato una destabilizzazione dei mercati d’energia e alimenti, e l’indurimento senza precedenti della politica monetaria per lottare contro un’inflazione che non si vedeva da decenni.
Gli esperti vaticinano una crescita lenta e disuguale.
Gli ottimisti parlano di una specie di atterraggio blando che per le nazioni in via di sviluppo non è stato né sarà, come d’abitudine, tanto fine come la piuma che sfiora il pavimento.
«Non c’è denaro», ha detto il recentemente eletto presidente dell’Argentina Javier Milei, nel suo primo discorso presidenziale, come sala d’attesa di un pacchetto di misure che colpirà categoricamente i più vulnerabili.
Il suo vicino, Luiz Inácio Lula da Silva, che è tornato al potere quest’anno vincendo contro Jair Bolsonaro, ha promulgato una legge che per la prima volta permetterà di far pagare le imposte agli investimenti conosciuti come fondi esclusivi d’investimento e anche come «supericchi».
In questo modo si pretende d’incassare l’equivalente a 6 000 milioni di dollari sino al 2025, e realizzare la sua promessa elettorale d’includere «i poveri nel bilancio e i ricchi nelle tasse sulle rendite».
L’anno 2024, appena cominciato, non potrà eliminare con una riga le sfide che gli consegna come in una gara a ostacoli 4x100, il suo predecessore.
L’umanità ha già vinto infinite volte il fuoco. Chissà, la prima volta che un uomo è stato davanti a una fiamma accesa, un bambino bello e vivace era appena nato. Ed esiste forse qualcosa più stimolante e pieno di speranza dello stesso arrivo della vita? ( GM/Granma Int.)