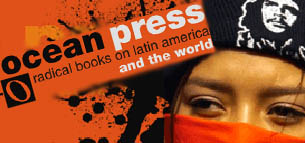Nel dicembre del 1953 Zavattini giunse per la prima volta a Cuba in transito per il Messico, dove doveva lavorare in alcuni progetti con Manuel Barbachano Ponce, produttore del film “Raices”, vincitore del festival di Cannes. A Cuba era stato invitato dalla società progressista “Nuestro Tempo” per assistere ad un ciclo di film italiani e scambiare impressioni con i giovani valori insiti in quella società d'avanguardia, entro la quale c’erano due cineasti usciti dal "Centro Sperimentale di Cinematografia": Tomás Gutiérrez Alea e Julio Garcia Espinosa.
In quell’ambiente, limitatamente al tempo, Zavattini conobbe la situazione del paese, le inquietudini dei giovani, del popolo, commuovendosi per l'assalto al Moncada, avvenuto appena cinque mesi prima.
In quegli stessi giorni di dicembre 1953 si celebrava il "Congresso di Parma", che esaminò la crisi del neorealismo, derivata da screpolature nella forma, contenuto e nella divergenza dei suoi adepti che subito culminò nella totale dissoluzione.
La conseguenza di quegli eventi portò Zavattini a fare un compromesso con i giovani cubani che vedevano il movimento neorealista e le sue figure come paradigma nella denuncia delle ingiustizie e della miseria, come efficace agente per trasformare una società che necessitava di cambi radicali.
La seconda visita di Zavattini a Cuba avvenne nel gennaio 1956, altro momento politico di agitazione popolare e repressione da parte della tirannia che trovò la massima espressione nei preparativi per lo sbarco del Granma alla fine dello stesso anno.
Questa volta, il cineasta italiano ebbe il privilegio d’assistere alla proiezione del documentario "El Mégano", realizzato da una équipe di giovani cineasti dell'Associazione Nuestro Tempo, Julio García Espinosa, Tomás Gutiérrez Alea, Alfredo Guevara, José Massip, Jorge Fraga e altri.
Gutiérrez Alea, riferendosi a Zavattini, disse:
"...si presentava con sufficiente fedeltà, riconosceva, tuttavia, che eravamo imbevuti da tutte quelle teorie neorealiste importate dall'Italia, nel rappresentare le dure condizioni di vita dei carbonari della Cienaga e lo sfruttamento di cui erano vittime... ".
Quel documentario, alla cui proiezione aveva assistito Zavattini, fu in seguito sequestrato dagli agenti del servizio segreto militare e recuperato dal Che nel 1959, quando lo riprese dagli archivi degli uffici preposti alla repressione delle attività comuniste (Brac).
Questa fu la Cuba che visse Zavattini, in due momenti chiave della sua storia. Quelli furono i giovani con i quali divise il suo tempo, le sue idee e inquietudini.
Al suo ritorno scrisse per la rivista Cinema Novo:
"... e pensare se fossero stati qui alcuni signori di via Veneto, alcuni letterati, udendo gli apprezzamenti che venivano fatti al nostro cinema fuori dall'Italia, avrebbero certamente avuto vergogna del proprio scetticismo. Dal cinema italiano gli stranieri si aspettano indicazioni di vita, stimolo nella lotta, come se noi italiani stessimo sempre lavorando per soluzioni non più in la del romantico... ".
Frutto di queste riunioni con i cineasti cubani fu l'intento di realizzare un progetto chiamato "Cuba mia", versione cubana di "Italia mia", nella quale attraverso piccole storie, con piena libertà di concezione di immagini, si presentavano importanti aspetti della realtà.
Questo progetto, purtroppo, non si concretizzò per mancanza di produttori, ma risultò una notevole esperienza e il preambolo di una collaborazione che senza saperlo allora, si sviluppò nella Cuba libera.
Tre anni dopo, nel dicembre del 1959, Cesare Zavattini tornò a Cuba, questa volta per due mesi, fino al febbraio 1960. Su questo fatto disse: "Mi considero un uomo fortunato per poter vivere nel cuore di uno degli avvenimenti del nostro tempo più reale e allo stesso tempo, più leggendario. Oltre all'importanza politica che ne deriva, per quello che è successo a Cuba, questo momento politico è un momento d’immaginazione, di prodezza favolosa, un momento che, per la sua eroicità, sembra una cosa accaduta in altri tempi... ".
L'obiettivo preciso di Zavattini era, a parte quello di conoscere a fondo il processo rivoluzionario, di offrire la propria collaborazione al processo costruttivo cubano.
Molti cubani erano a conoscenza delle sue precedenti visite ed erano felici di avere una collaborazione così ricca di conoscenze letterarie e cinematografiche, per sviluppare un cinema totalmente nuovo che riflettesse con verità i cambi che in ogni minuto si manifestavano nel paese.
La prima riunione avvenne nel neo costituito Icaic (la cui creazione fu la prima legge culturale del Governo Rivoluzionario), revisionando materiali e idee, sull’investigazione di un argomento che fu fedele testimonio del momento. Da qui sorse la necessità che portò Zavattini ad informarsi con maggiore precisione sul paese, la sua storia, la sua gente, per cui i primi 20 giorni furono ciò che lui amava definire "ambientazione storica".
In contemporanea con questi tempi d’ambientazione, impartì un corso tecnico per l'elaborazione di guide, ricordando ai partecipanti:
"Quando andrò via da Cuba, voi saprete quello che so io... ma il primo e il miglior corso tecnico che si può apprendere è quello di una Rivoluzione come quella cubana. Quella può esprimere i migliori elementi, le migliori condizioni per scrivere magnifiche guide... ".
Così Zavattini approfondì la problematica nel contesto, nella comprensione dell'idiosincrasia del cubano, nelle principali necessità di orientare la critica, di orientarsi verso uno stile:
"La necessità di uno stile cubano nel cinema, scrisse, non significa che tutti gli artisti cubani devono filmare nello stesso stile, che ma tutti devono rispondere ad una unità politica, morale, umanista, che deve essere comune".
Conferenze, interviste, scritti febbrili: Zavattini era allucinato nell'esaminare tanti avvenimenti vertiginosi in un paese in cui la libertà era una realtà, in cui vi era materiale ricco e sufficiente per utilizzare centinaia e centinaia di metri di pellicola, un paese in cui ancora vi era la possibilità di creare quello che lui stesso non aveva potuto ottenere nella sua lontana patria.
Dopo molti giorni di scambi, di discussioni su nuove forme per produrre documentari, notiziari, lungometraggi che facessero comprendere al mondo la nuova e promettente realtà cubana, di analisi di progetti per riassumere problemi storici, politici, sociali e artistici, decisero di optare per un argomento che riuniva tutte queste caratteristiche:
"Si tratta di un ragazzo di 14-15 anni che vive sulla Sierra. È un argomento incredibile per lo straniero... " segnalò Zavattini, concependo quello che un anno dopo si convertì nel quarto lungometraggio dell'ICAIC con la regia di Julio García Espinosa: "Il giovane ribelle".
Così si materializzò la visita di Cesare Zavattini a Cuba, che fu soprattutto, una lezione di generosità senza limiti e, per ambo le parti, la realizzazione di un sogno.
Zavattini non tornò più a Cuba, prima per ragioni di lavoro e poi di salute. Ebbe però sempre nei suoi ricordi l'isola, la gente che conobbe, la rivoluzione che appoggiò e difese, com'è riportato nei suoi messaggi, nelle sue lettere, nelle sue memorie.
Di quel remoto viaggio nel 1953, già perso nel tempo, scrisse: "Pensavo se era giusta l'incisione che avevo visto scritta sul muro, nella sala di proiezione dell'Università: Lumiere, Edison, Meliès, Porter, Griffith, Wiene, Chaplin, Eisenstein, Murnon, Flaherty, Disney, Laurence Olivier... Pensavo che tra questi nomi doveva esserci pure quello di qualche regista italiano o che ci fosse almeno la parola neorealismo.
Non per quello che ha fatto, ma per quello che farà".
Testo tratto da: Jesús Vega, “Zavattini en La Habana” (La Habana, Unión, 1994) e da vari articoli della Rivista "Bohemia" degli anni '60. (Traduzione Francesco Nespoli)